#Racconti dal
Real Bosco
Contest ispirato
alla fauna
e alla flora
del Real Bosco
di Capodimonte
Per festeggiare la riapertura del Real Bosco di Capodimonte gli Amici di Capodimonte hanno invitato i suoi visitatori a tornare a godere del più grande giardino e parco pubblico della città, e rielaborare in chiave creativa i pensieri, le sensazioni e le emozioni che ciascuno di noi vive a contatto con la natura o con le sue rappresentazioni artistiche. L’iniziativa è stata curata da Alessia Attanasio e Martina Tramontano.
I partecipanti del #contest digitale #RaccontidalRealBosco hanno potuto scegliere di inviarci un testo (autografo o selezionato da altri autori della letteratura), una fotografia, un disegno, oppure entrambi, da cui si evinceva un legame con il Real Bosco di Capodimonte o con un’opera del Museo.
Di seguito le opere a nostro avviso più originali. I vincitori hanno potuto scegliere fra il percorso guidato gratuito per max. 2 persone tra le collezioni del Museo di Capodimonte o tra la flora e gli edifici del Real Bosco e la loro storia!
Contributo di Sergio Palumbo
” ‘O bbosco e Capo ‘o monte”
‘Addore ‘e ll’erba ‘nfosa,
‘o sciù sciù sciù d’o viento
ca frena ‘mmieze ‘e ffronne,
ll’auscielle che, ‘nzerriuse
zenneano e vaveano.
Guaglione, cu ll’amici
‘a palla e ‘a bicicletta
crescévamo piglianno
funghe e ciclamine,
ghiande, castagne e sierpi.
‘A via d’a sera ‘o ttarde,
migliare ‘e stelle ‘ncielo
‘nzieme ch’ ‘e ‘llucia luce,
brillavano into all’uocchie.
E dinto a stu cuncierto,
c’addore e co’ sapore
do llauro e d’ ‘e mmore,
venette ‘o primmo ammore.
Songo passate ll’anne
E ancora passarranno
E io stongo sempe ‘cca;
passeo pe’ dinto e viali
e quanno ‘nchiuro ll’uocchie,
veco ca m’e tignuto,
cu tutte e sfumature d’o vverde,
‘o sango e ‘o core.
‘A vote m’ alluntano
ma po’ ‘na frennesia
me votta a dinto ‘o lietto
me vesto e vengo ‘cca
Respiro e m’abbandono,
stiso into all’erba ‘nfosa,
comme a ‘na communione
io..me cunfesso e tu,
..tu sempe me perduone.

Contributo di Fiorella Barrella
Non meno che le statue divine dove splendono oro e avorio,
adoriamo i boschi sacri e, in questi boschi, il silenzio.
(Plinio il Vecchio)

Contributo di Fiore
“Chiunque sia in grado di mantenere la capacità di vedere la bellezza,
non diventerà mai vecchio”
F. Kafka


Contributo di Stefania Ioppolo
MUSEA E CORVO
In un bellissimo bosco, non molto lontano da qui, c’erano una volta il Regno di Sopra e il Regno di Sotto. Erano divisi dalla Porta di Mezzo, ma i loro abitanti vivevano in armonia e potevano attraversarla liberamente, finché un bel giorno la strega Pandèmia lanciò un incantesimo sui regni, sulla porta e su tutto il bosco.
Pandèmia non era stata sempre una strega, in realtà tanto tempo prima era una bellissima fata di nome Pandòra innamorata del giovane principe Capodimonte, il quale però non essendosi mai accorto di lei aveva sposato la figlia del re del Regno di Sotto. Per la delusione d’amore la fata volle cancellare la bellezza di quel bosco tanto amato dal principe e l’armonia tra gli abitanti dei due regni; il suo incantesimo fece inaridire tutto, e chiunque avesse cercato di attraversare la porta ne avrebbe pagato le conseguenze. L’incantesimo trasformò la fata in strega, e Pandòra divenne Pandèmia; la strega si rifugiò in una grotta abbandonata in un angolo solitario del bosco, e sua unica compagnia fu una vecchia volpe che qualche volta gironzolava da quelle parti. Il re Capodimonte, afflitto dall’irrimediabile tristezza in cui era sprofondato il suo regno e tutto il bosco, morì pochi anni dopo, lasciando la sua giovane moglie e la piccola principessa Musèa.
Come conseguenza dell’incantesimo gli abitanti dei due regni non poterono più uscire e incontrarsi, tutti avevano perso la gioia e l’allegria, e nel bosco non ci furono più fiori, alberi e prati verdi. All’ingresso del Regno di Sotto, nella piazza a semicerchio, le dodici guardie reali erano state trasformate in statue di marmo, e dei sette viali che da qui partivano solo uno restò percorribile per arrivare al palazzo del re, gli altri finivano diritto nel fitto del bosco da dove non si poteva più fare ritorno. Dall’altro lato della Porta di Mezzo c’era invece il viale che portava al Regno di Sopra, e gli alberi che erano ai lati, si diceva fossero gli antichi abitanti che avevano cercato di attraversare la porta. Nel bosco la vita si fermò e un principe dal cuore di pietra, vestito tutto di nero, ne approfittò per impadronirsi del Regno di Sotto. Si fece chiamare da tutti re Corvo e andò a vivere con la sua corte in una Torre nella parte più lontana del bosco, dove volavano giorno e notte grossi uccellacci neri.
Nel Regno di Sopra la giovane regina Musèa, viveva da sola nel suo palazzo e dopo la morte della regina sua madre non era più uscita né dalle sue stanze né si era più affacciata dal Belvedere per ammirare lo spettacolo del mare al tramonto e dell’Isola delle Sirene. Avendo saputo della sua disgrazia, dai regni vicini le inviavano ogni giorno regali tra cui dei bellissimi quadri per rallegrarla, ma Musèa era inconsolabile.
Nei due regni, l’unico che pareva non aver subito l’influenza dell’incantesimo era Munaciello, che viveva nel tronco cavo del Grande Canforo. Solo lui poteva attraversare la porta e tutto il giorno saltellava da una parte all’altra del bosco facendo scherzi e dispetti ai pochi malcapitati che incontrava.
Una notte più buia delle altre però le guardie lo catturarono mentre era nel frutteto del re Corvo e lo portarono alla vecchia Torre. Alla presenza del re, Munaciello incominciò a piagnucolare che non stava rubando e che lui non sapeva niente; era davvero un gran bugiardo, ma Corvo lo aveva fatto portare lì per un altro motivo: aveva infatti sentito dire che nel Regno di Sopra, nel palazzo in cui viveva Musèa, si conservava un’armatura appartenuta al re che rendeva invincibile chiunque la indossasse in battaglia, e sapendo che l’ometto era l’unico a poter circolare liberamente nei due regni, pensò di approfittare della sua furbizia e della sua abilità per impadronirsene. Munaciello fu costretto ad aiutare Corvo per non essere imprigionato e così andò da Musèa. Con la scusa di farla divertire con i suoi scherzi entrò nel palazzo e portò via la prodigiosa armatura.
La fata Ciclamina, una fatina piccola piccola che insieme alle sue sorelle viveva nella radura del bosco, aveva notato Munaciello attraversare la porta con un pesante sacco sulle spalle e lo disse alla regina che, insospettita, si accorse che mancava l’armatura del padre; il giorno dopo Munaciello fu rimandato da Corvo con il messaggio di restituirle immediatamente quello che le apparteneva. Il re rispose che avrebbe restituito l’armatura solo se Musèa fosse andata a riprendersela di persona, ben sapendo che a causa dell’incantesimo la regina non avrebbe mai potuto attraversare la Porta di Mezzo. Musèa non sapeva come fare, si chiedeva in che modo si poteva annullare l’incantesimo e Ciclamina le disse che l’incantesimo sarebbe stato sciolto solo quando il bene avesse sconfitto il male. Allora Musèa, pur sapendo i rischi che correva, uscì dal suo palazzo per recarsi da Corvo così come questi voleva, ma proprio nel momento in cui stava attraversando la porta, il re passò lì nei pressi e la vide. Era così pallida che sembrava un’apparizione e il re rimase ammirato dal suo coraggio e dalla sua bellezza. Musèa riuscì ad attraversare la porta indenne, e incredula di quanto era accaduto prese uno dei viali senza rendersi conto di aver sbagliato strada, finché non si trovò davanti alla grotta di Pandèmia. Pandèmia vide arrivare Musèa e le andò incontro chiedendole come avesse fatto ad arrivare fin lì; la regina allora le chiese il perché di quell’incantesimo malvagio e la strega le raccontò dell’amore per il re Capodimonte e della delusione che l’aveva resa così cattiva. Intenerita da questo racconto, Musèa le prese la mano chiedendole di accompagnarla da Corvo. Questo gesto gentile trasformò di nuovo la strega nella bella fata Pandòra.
Arrivate alla Torre anche Corvo, vedendo la strega ritornata fata, volle conoscere tutta la storia. Ascoltando Pandòra non riusciva ad immaginarsi la bellezza dei regni prima dell’incantesimo, e poi disse a Musèa di averla vista attraversare la porta e di esserne rimasto colpito: questo spiegava perché l’incantesimo non aveva avuto effetto su di lei. Dopo questo racconto Corvo disse a Musèa che era stanco delle guerre e desiderava cambiare vita e le restituì l’armatura. Sorrise per la prima volta in vita sua e Musèa ne fu così affascinata che gli prese la mano. In quello stesso istante avvenne un’altra magia: Pandòra si trasformò in una colomba bianca e volò in alto sugli alberi, gli uccellini del bosco ripresero a cantare e nei prati ricominciarono a fiorire le margherite.
Rimasero tutti sorpresi da quanto stava avvenendo, l’incantesimo era finalmente sciolto, la vita era ritornata nel bosco. Gli abitanti dei due regni per la felicità organizzarono nel Prato delle Sette Querce una festa che durò sette giorni e sette notti. Dopo qualche tempo Musèa e Corvo si sposarono e per il pranzo di nozze dei bravissimi artisti del regno donarono loro dei magnifici piatti di porcellana. Da quel giorno tutto cambiò e i due regni divennero il Regno di Capodimonte. Tutto cambiò tranne Munaciello, che continuò a vivere nel Grande Canforo e a fare dispetti a tutti e se guardate bene, nelle notti senza luna è ancora lì a fare scherzi a chi passeggia nel bosco.

Grazie a tutti i partecipanti per aver voluto condividere con noi le proprie storie, i propri scatti fotografici e i propri ricordi.
Contributo di Concetta Umbriano



Contributo di Antonella Ventinucci
NATURA
In una dimensione
Che non conosce tempo e spazio,
Natura rapisce.
Corpo e terra cedono
All’irresistibile attrazione,
Come fossero magneti,
Armoniosamente travolti
Da una leggera brezza primaverile.
Sulle note di dolci versi,
La mente sogna,
Gli occhi brillano,
Natura prende forma.
Il suo fascino travolgente dona
Incanto,
Bellezza,
Ovunque essa sia,
Natura.
Antonella Ventinucci

Contributo di Anna Calì
Il cielo è di tutti
Gianni Rodari
Qualcuno che la sa lunga
mi spieghi questo mistero:
il cielo è di tutti gli occhi
di ogni occhio è il cielo intero.
È mio, quando lo guardo.
È del vecchio, del bambino,
del re, dell’ortolano,
del poeta, dello spazzino.
Non c’è povero tanto povero
che non ne sia il padrone.
Il coniglio spaurito
ne ha quanto il leone.
Il cielo è di tutti gli occhi,
ed ogni occhio, se vuole,
si prende la luna intera,
le stelle comete, il sole.
Ogni occhio si prende ogni cosa
e non manca mai niente:
chi guarda il cielo per ultimo
non lo trova meno splendente.
Spiegatemi voi dunque,
in prosa od in versetti,
perché il cielo è uno solo
e la terra è tutta a pezzetti.

Contributo di Ciro Capuano


Contributo di Maria Castaldo
Mondo, sii, e buono;
esisti buonamente,
fa’ che, cerca di, tendi a, dimmi tutto,
ed ecco che io ribaltavo eludevo
e ogni inclusione era fattiva
non meno che ogni esclusione;
su bravo, esisti,
non accartocciarti in te stesso in me stesso.
Io pensavo che il mondo così concepito
con questo super-cadere super-morire
il mondo così fatturato
fosse soltanto un io male sbozzolato
fossi io indigesto male fantasticante
male fantasticato mal pagato
e non tu, bello, non tu «santo» e «santificato»
un po’ più in là, da lato, da lato.
Fa’ di (ex-de-ob etc.)-sistere
e oltre tutte le preposizioni note e ignote,
abbi qualche chance,
fa’ buonamente un po’;
il congegno abbia gioco.
Su, bello, su.
Su, Münchhausen.
Andrea Zanzotto

Contributi Caterina Rebecchi
Un respiro soltanto
Un tempo
Ho creduto d’essere di legno
Come un albero;
Incatenata
Alle radici del mio passato;
Come foglie
Adesso
Tremano
Le mani
fragili e rugose,
Stremate dal lavoro di lunghi anni.
Mi Culla dolcemente il vento,
Accarezza le gote
E canta una tenera ninna nanna;
Torno bambina
Sorrido;
L’ombra si allontana,
Arriva il sole:
Luce divina,
Riserva d’amore,
Lentamente assorbo
La tremula energia;
La respiro,
L’accolgo
In questo abbraccio di luce
Di una nuova vita;

Contributo di Marianna Guida
LUCERTOLINE E ABBANDONI
Di Marianna Guida
In una giornata di luglio mi ritrovo con la mia amica Maria su una panchina del Bosco di Capodimonte. Lasciandoci alle spalle il bruciante caldo cittadino, entriamo in un’atmosfera gradevole e lieve, un locus amoenus che favorisce innocue facezie tra amiche che si conoscono da talmente tanti anni da rendere possibili i silenzi senza che questi si carichino di imbarazzo; è contemplata perfino una ammissione totale di fragilità, come se finalmente fosse lecito abdicare dalle aspettative della socialità. Questo è uno spazio sacro fatto di cazzate. Siamo così, mentre una lieve brezza sopraggiunge a rendere ancora più leggere le nostre chiacchiere, Quand’ecco materializzarsi una bambina di circa quattro anni. La sua apparizione è così subitanea da far pensare che stesse già li prima che noi occupassimo la panchina, che fosse, addirittura, una creatura del bosco benevola e birichina venuta vicino a noi per confermarci la sostanza eterea e volatile delle nostre confidenze. È ferma nel suo approccio, dotata di un’assertività di cui io ignoro in me stessa financo la possibilità di affiorare, anche nei momenti di maggiore autoefficacia. Ha i piedini scalzi e neri, un vestitino preziosissimo che indossa con noncuranza, i capelli corti e biondi con una frangia alla Giovanna d’Arco. In mano ha una minuscola lucertola che ci mostra orgogliosa. In lei non c’è, tuttavia, alcun compiacimento predatorio per la cattura che immagino sia stata tutt’altro che semplice. Allora la mia amica le dice di non stringere e di lasciarla andare quanto prima. Lei, evidentemente educata da verdi-New Age-figli-dei-fiori annuisce convinta, sostenendo di tenerla in mano solamente per proteggerla da incauti piedi che potrebbero calpestarla. La lascerà andare, dice giudiziosa, perché gli animali devono essere liberi. Però soggiunge: la poggerò sull’albero, perché sul prato non mi fido. È convinta, la nostra piccola animalista, e accarezza la lucertola talmente immobile da sembrare un giocattolo. La bambina si chiama Uma, e allora capiamo. Da dietro l’albero vediamo sfolgorare un sorriso che è quasi una specie di saluto al sole. È la mamma animalista della bimba scalza. Mi si avvicina, la piccola Uma, per spingermi ad accarezzare l’immobile rettile. Vinco un’istintiva repulsione e accarezzo l’animaletto, mentre Uma mi dice: Mica hai paura, vedi come è dolce, mi ha pure dato un piccolo morsetto. Ma dopo pochi istanti la lucertola cerca di svincolarsi provando a sfuggire alla premura di Uma. Dopo un attimo le rimane in mano solo la coda. Fosse successo a me a quattro anni sarei morta, per il fastidio-schifo procuratomi da simile auto-dissezione, ma soprattutto per il senso di colpa, cioè per aver io stessa provocato un fenomeno così forte e apparentemente autodistruttivo. Uma no, non si scompone, pur apparendo evidentemente contrariata e dispiaciuta. Conosce da un punto di vista scientifico il fenomeno, ma, nonostante ciò, insegue l’animaletto nell’erba. Non riesce più a trovarlo, però, e stringe a sé la codina che le è rimasta in mano. E quel gesto mi commuove perché mi fa pensare a tutto ciò su cui riversiamo il nostro amore e che, nonostante il nostro attaccamento, sparisce nel fitto dell’erba, lasciandoci con una codina in mano. Uma accetta l’evidenza delle manifestazioni della natura ma poi capiamo che sta tramando qualcosa, perché un attimo dopo la vediamo interagire animatamente con uno dei sorveglianti. La differenza di statura e di età non scalfisce la sua grinta e la consapevolezza che proietta come una luce cristallina attorno a sé. E per oggi le apparizioni misteriose e luminose sono finite. Grazie di esistere, Uma!
Contributo di Deborah Lombardi
Il sentimento del bello è il fondamento del gioco, l’arte nasce proprio da quel particolare stato di grazia, disinteressato e a-finalistico, sottratto all’influenza del sensibile, che è il gioco. L’attività ludica è esercizio di esteticità e l’arte è superiore manifestazione della libera potenza creativa del gioco” (Friedrich Schiller, 1759-1805).

Già il Pulci, che venne a Napoli nel 1471, ricordava in un sonetto che la “foglia” era uno dei vanti della città, e Antonio Abbondanti da Imola in un’opera del 1629, dopo aver proclamato che Napoli era più importante di ogni città “del nostro mondo”, cantava la bellezza di questo “luogo” dove “par che la natura signoreggi ” e che sempre “april verdeggi / fra cavoli torzuti e foglia molla/ e fra quei gran signor de’ sette seggi”

Contributo di Marinella Lupieri
VAGANDO E DIVAGANDO NEL BOSCO
Lo sguardo perso nell’azzurro del cielo, si abbassa tra i due gruppi di palme per bearsi della vista della fanciulla addormentata, l’isola azzurra che giace all’orizzonte. Una brezza leggera mi accarezza le guance con la stessa levità delle le dita di mia madre. Sul mare i gabbiani con le ali spiegate si lasciano portare dalle correnti ascensionali, liberi e rilassati. Mi giro per raggiungere il lato opposto del parco in un pellegrinaggio di nostalgia, d’amore e dolore. Ritto su di un cespuglio un merlo fischia in cerca di una compagna; nelle aiuole i colombacci frugano nell’erba, alla ricerca di nutrimento. Io mi nutro di bellezza, dell’arte e della musica che vengono dalla natura. Attraverso la Porta di Mezzo, con la sensazione di entrare in un altro mondo, un bosco incantato abitato da fate e fuochi fatui. Le fate narrano della bellezza dei prati, delle cacce dei re, delle passeggiate delle principesse, dei giochi con la palla dei bimbi che vedo ridere felici. Sento anche il trillo felice della cinciallegra, fischietto anch’io, la cerco tra i rami ma non la vedo. Lei risponde al mio fischio e mi basta sapere che c’è per sentirmi serena. Continuo a camminare e a ricordare. I fuochi fatui raccontano del dolore delle persone che qui si rifugiarono tanti anni fa. Guerra, la strega cattiva che tutto ingrigisce dove passa, aveva spento i colori della terra di mia madre e di altri trecentomila. Costretti a fuggire dall’Istria, dalla Dalmazia, da Fiume alcuni trovarono ospitalità in baracche costruite alla svelta sotto le stesse magnolie che videro le magnificenze dei re: lamiere come pareti e come tetti, fredde d’inverno, calde d’estate. Nei prati si faceva il bucato in lavabi improvvisati e le corde per stendere erano tra gli alberi. Un grande recipiente conteneva l’acqua e un ramaiolo che tutti utilizzavano per bere. Da qualche parte crescevano i funghi e i ragazzi del Borgo di Capodimonte che lo sapevano, li nascondevano sotto le foglie secche per timore che i nuovi arrivati gli togliessero un magro pasto. A scuola si ritrovavano, napoletani e fiumani, polesani e dalmati a dividere giochi, studio e miseria. Sotto i lecci, i tigli e gli aceri si aggiravano persone che avevano perso tutto ma si innamoravano, si sposavano, accompagnavano i figli a scuola e al catechismo e piano piano si rifacevano una vita attraverso il lavoro. Alcune famiglie restarono fino agli anni sessanta ma poi quasi tutti quegli italiani onesti e laboriosi, che lasciarono la terra natia per restare italiani, quelli che resistettero e non impazzirono né si suicidarono né si uccisero con l’alcool, si inserirono nelle nuove realtà che li avevano accolti. Mia madre non passò dal Bosco: suo padre era in un altro campo, a Fuorigrotta, e per poterlo rivedere venne a Napoli e s’innamorò perdutamente di una città che aveva Pola nel nome e tanto gliela ricordava nel mare, nell’arte e nell’archeologia. Una città di mare, un porto, una mentalità aperta che rimpiangeva, costretta com’era in una piovosa e grigia città del nord. Si trasferì, con la bambina che ero. Aveva frequentato il liceo artistico, amava la classicità, la bellezza e gli alberi. È stata la prima a portarmi qui e ad insegnarmi ad amare il bello, che sia opera di Dio o dell’uomo. Restò sempre una polesana, ma amò e difese sempre Napoli a spada tratta, si “ammalò” di Napoli. Verso la fine della vita manifestò il desiderio di tornare almeno una volta a Pola, ma il destino non ha voluto che accadesse. Mentre penso a tutto queste cose sono arrivata davanti alla Casina della Regina: quando c’era la baraccopoli, qui si era stabilita la Croce Rossa che si occupava di igiene e sanità. Di fronte, oltre un altro grande prato di smeraldo, la targa che ricorda come Napoli accolse quegli sfortunati. Per osservarla mi siedo sulla “nostra” panchina: l’ho voluta io, e l’ho voluta proprio lì. C’è scritto: ho tanto amato Pola, ho tanto amato Napoli. Mia madre viene a sedersi accanto a me: non piange più, il suo ultimo esodo, da questa terra al cielo, l’ha consolata, l’ha innalzata al di sopra di tutte le miserie e i sentimenti umani per proiettarla nell’Amore divino che tutto comprende e tutto perdona. Ora ci son io, con i suoi geni che mi domando chi sono: ho imparato il suo dialetto, ma anche il napoletano, ho imparato ad amare l’Istria ma anche Napoli. Quando mi viene “appocundrìa” è a Partenope che penso, affascinante sirena che ti ammalia con la bellezza e il canto. E mi ritrovo tra i sentieri del Parco, a chiacchierare con mia madre che sola può capire questa malinconia canaglia. Abito vicino a quel confine da cui mia madre aveva giurato che sua figlia sarebbe stata per sempre lontana. Ogni volta che torno a Napoli la visita al Bosco è d’obbligo, non posso farne a meno, mi aspetto che tortore e merli, passeri e cince mi salutino come persona conosciuta e che mia madre venga all’appuntamento sulla nostra panchina per immergermi nel verde e nel silenzio pieno di trilli del Bosco.




Contributo di Massimo Rosario Meglio

Contributo di Brigida Mele

Contributo di Serena Milano
Persa in te
Persa tra il rumore delle foglie che si accarezzano delicatamente e sul volto il calore di un sole gentile che si fa spazio tra i rami.
Tu Natura, Regina e Vita di questo Bosco.
Non ti dirò quanto sei maestosa, ma quanto sei intima.
Io in te mi perdo, quando tutto tace, all’ombra dei tuoi viali, al sicuro nella tua bellezza.
Perché qui tutto è semplice, tutto è rimasto com’era, come dev’essere.
Non parlerò della tua maestosità, ma quanta intimità regali a chi ti fa visita.
Ascolta: Il rumore di una carrozza, il vento che mi sussurra una leggera melodia!
Qui tutto è facile, tutto è passato, ma tutto è rimasto.
Chi ti fa visita… rimane.
Mi sembra di vedere le ombre di tutti. Ed ecco che passa sfrecciando un gruppo di bambini che si fa largo tra la folla, una signora anziana è lì con il suo cucciolo, più in là c’è qualcuno che ha avuto una giornata difficile e si riposa su una tua panchina. In lontananza sembra di sentire un bambino che sta imparando ad andare in bici senza le rotelle. Proprio qui, proprio ora. Il padre lo sprona, ma lui inizia a piangere credendo di non potercela fare. Sii buono con lui, aiutalo ad essere meno severo con sé stesso e a credere nella sua forza.
Qui si susseguono felicità condivisa, tristezza che cerca consolazione, tenerezza di piccoli momenti significativi.
Non sei maestosa, sei la madre di tutte queste vite.
Tu sei compagna e cura.
Chiudo gli occhi, mi abbandono in te,
ancora una volta.
Sto camminando, mi sono persa… nonostante conosca a memoria ogni tua strada.
Forse è così che dev’essere, non lasciarti scoprire.
Facci perdere ancora in te!
Scegli tu chi deve rimanere, io mi accontenterò di sdraiarmi un po’ sotto uno dei tuoi tanti figli.
Chiudo gli occhi, mi abbandono in te, ancora una volta.
Mi accarezzi ancora un po’?
Tua Serena
Contributo di Valeria Papa
29 Settembre 1943
Ci sono gesti quotidiani che restano fermi nella memoria. Quel giorno, ad esempio, preparavo patate per cena. Nella tranquillità della nostra casa in Via Santa Maria delle Grazie, mentre mio padre era sulla sedia nel soggiorno e io in cucina con la bambina che dormiva beata tra le braccia, un ordine tuonò dalla soglia di ingresso. “Alle hinaus!” Uno schianto, e la porta fu spalancata con violenza. Davanti a noi tre uomini in uniforme, con aria austera, puntavano il dito contro mio padre e la bambina. Sapevo che quando si aveva a che fare con loro bisognava essere accondiscendenti, se si voleva restare vivi, ma il buon senso spariva dinanzi all’istinto di madre. Riuscii a intuire che volevano prendere la piccola e portarla via. L’abbracciai ancora più forte, premendone la testolina contro il petto. Il suo profumo invadeva le mie narici come fosse la prima volta. Mi allontanai da loro scuotendo la testa senza aver la forza di pronunciare una parola. Vittoria aveva solo due anni, cosa potevano mai volere da lei?
Mio padre si intromise – con un sorriso tirato – e cominciò a parlare in un tedesco fluido e sicuro. I soldati, che fino a poco prima sembrava volessero radere a suolo casa, si guardarono stupiti. La sua figura slanciata, la muscolatura ben definita, gli occhi e i capelli chiari, la padronanza della loro lingua, gli davano un vantaggio. Li invitò a sedersi e mi ordinò di servire un piatto di patate ai nuovi ospiti affamati (da cuoco girovago, certo che fosse tra i piatti prediletti dai tedeschi). Mi riscossi dal tremore che nel frattempo aveva preso possesso del mio corpo e ripresi a cucinare. Servii i piatti e senza proferir parola mi allontanai con la bambina. Appena terminarono il pasto, salutarono mio padre con un cenno ormai famoso tra le strade di Napoli, che lui si trovò costretto a ricambiare con finta fierezza prima di chiudere la porta. In casa calò il silenzio. È incredibile quanto un’emozione così astratta come la tensione, possa diventare tanto palpabile. Temevo di rivolgere la parola a mio padre, e intanto la mia mente era affollata di domande. Riuscii a pronunciarne solo una, la più stupida forse: “Conosci il tedesco?” Lui si passò la mano sul viso, improvvisamente stanco. Sapevo che conosceva il francese – nato a Marsiglia, scappato di casa quando aveva appena sette anni – venuto poi in Italia aveva appreso anche la nostra lingua. Rispose che grazie ai lavori che aveva fatto nei primi anni nel nostro Paese, aveva imparato lo Spagnolo, il Russo e il Tedesco, appunto. Mi spiegò poi che quella mattina, un auto militare in transito a Porta Piccola, era stata raggiunta da alcuni spari e il conducente era stato trovato privo di vita. I soldati della Divisione Goering erano alla ricerca dei colpevoli, rastrellando uomini e bambini di tutto il quartiere. Guardai Vittoria con aria interrogativa, non ci fu bisogno di porre la domanda, l’aveva intuita: avevano confuso la bambina per un maschio. “A pancia piena si ragiona meglio” mi disse. Tra un boccone e l’altro implorò di risparmiarci. Aveva inventato la storia che ero rimasta incinta di un poco di buono per poi essere abbandonata con la bambina. Quella bugia ideata su due piedi, i modi nobili che mio padre aveva conservato come le sue origini volevano, il modo sicuro nell’esprimersi come un loro pari, e lo stomaco che non brontolava più, li aveva convinti a lasciarci in pace. Tornò a sdraiarsi sulla sedia con un sospiro, io lo imitai con Vittoria ancora dormiente tra le braccia. Dopo una notte insonne, ci rifugiammo tra le pareti di casa anche il giorno successivo.
Seppi da donna Carmela – la portinaia del palazzo – che centinaia di uomini erano stati salvati grazie all’intercessione della signora Schmitt, una donna di origini tedesche che viveva nel nostro borgo da quasi vent’anni, ma purtroppo quattro prigionieri erano stati trattenuti per un’esecuzione che si sarebbe tenuta quel pomeriggio stesso nel Real Bosco di Capodimonte, a due passi dalla nostra abitazione. Avrò lavato piatti e pentole con una minuziosità mai avuta prima. Lo sguardo nel vuoto e le mani nell’acqua per un tempo indefinito. Pensavo alla signora Palumbo, che aveva visto marito e figlio (appena quindicenne) portati via, messi in fila, costretti a scavarsi la fossa nella quale sarebbero stati giustiziati. Davanti a loro, la folla di amici, conoscenti e semplici curiosi che popolavano il quartiere. Alle 15,15 del 30 settembre 1943, uno sparo irruppe nel cupo silenzio della vegetazione. Il pianto di Vittoria mi scosse, corsi a prenderla nella sua culletta. Tentai di confortarla con gesti gentili e parole dolci, mentre le mie lacrime, mute, presero a bagnarle il suo candido vestito. Ora Vittoria è una bambina di otto anni. Con la famiglia riunita, andiamo volentieri a passeggiare proprio lì, al Bosco di Capodimonte. Correndo tra l’erba che sfiora le sue gambine scoperte baciate dal sole, sorride voltandosi. La richiamo con voce ferma, e le sorrido anche io. Gesti di una quotidianità semplice, che ci è stata concessa da chi ha perso la vita per fare in modo che noi potessimo avere una libertà mai più scontata. Alzo lo sguardo verso un cielo azzurro, limpido (come gli occhi della mia bambina), in un silenzio colmo di gratitudine.
Contributo di Erika Rebecchi
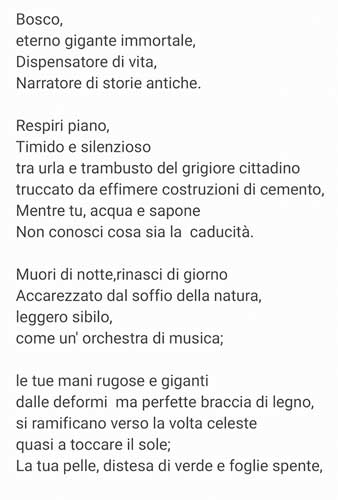

Contributo di Isabella Schiavo


Contributo di Sharon Vanoli
Capodimonte
Sharon Vanoli
Lentamente salivo scuri gradini. Ormai giunta in cima, sollevai lo sguardo dalle pietre. Non mi aspettavo di trovarlo: eccolo. Un robusto tronco chiaro, e poi, più in alto, la sua bella chioma di primavera. Proprio a un passo dai miei piedi, terminata la salita, lui mi aspettava, come una grande porta verde in mezzo al traffico. Credevo mancasse molto alla mia meta; a guardar giù, dietro di me, la città mi pareva ancora un assalto. Ma intuii subito, vedendo l’albero, che era questione di poco tempo. La collina di Capodimonte si apriva, da lì, tutt’intorno a me. Superai il tronco, ed era di nuovo la strada. La costeggiai su un lato, e poi sull’altro, sempre seguita dalle macchine, sempre in salita. Attraversai un’ultima volta, al semaforo; infine ecco il grande cancello spalancato, e il verde di un prato – tanto verde – appena oltre la soglia. Nel luogo da cui venivo, non c’erano parchi, ma natura libera. Ampi sentieri in mezzo al bosco; altri, scoscesi, si muovevano a singulto fiancheggiando i burroni. E sempre, da qualsiasi altitudine, il profilo prospero delle montagne. Il mare, tuttavia, non c’era. Quando mi trasferii a Napoli, dal mio paesino del Nord, passai le prime settimane rannicchiata di fronte all’acqua. Scendevo – guardinga, perché non ero certa che si potesse – una delle poche scalette che dal lungomare di via Caracciolo consentivano l’accesso al mare; e lì stavo, nascosta tra gli scogli, a fissare la superficie placida e bluastra, fino all’orizzonte, dove si delineava, nelle mattine limpide, la sagoma di Capri – sempre sbiadita, per via della distanza, come una terra galleggiante di fumo. Se qualcun altro si univa al mio angolo raccolto, ne avevo dispiacere, e un senso cupo di intrusione. Non sapevo cosa fosse la natura senza solitudine. Un po’ a fatica, mi ci abituavo. L’interazione stessa, tra me e il mare, mi pareva anomala. Fino a quel momento della mia vita, il mare era sempre stato quello delle vacanze estive: bagni a tutte le ore, sale nella bocca. Ma a Napoli il mare non si vive: si guarda. Questo me lo insegnò il primo volto con cui interagii, in città, quando ancora non conoscevo nessuno. Era un uomo molto riservato, di Cuma, sui quarant’anni. Parlava sempre con voce bassa e incerta, come bisbigliando. Gli spiegai la frustrazione che avevo riguardo al mare, che non si poteva toccare a piacimento, possedere con gioia. Lui mi fissò sorpreso. Nei piccoli occhi grigi, la luce del sole tremolava, quasi d’argento. Non disse niente. Soltanto si spinse, dal marciapiede, contro il muretto. E guardò di fronte a sé, molto seriamente, invitandomi a fare altrettanto con un gesto della mano. Allora capii che bisognava cambiare intenzione, che il mare – per lui, come per altri – non era affatto un gioco, ma contemplazione. Nelle grandi distese del parco si radunavano i gabbiani. Io li osservavo un po’ stupita, ché gabbiani a zampettare in un prato non ne avevo mai visti. Dappertutto, camminando tra i viali alberati, mi arrivava un odore forte e buono – come di tiglio, ma non so: nella vegetazione del Sud non mi orientavo. Dopo qualche giro, mi sdraiai sull’erba. Era la fine di aprile, o forse già maggio. Si stava bene, nel tempo mite del primo mattino. Intorno a me, quasi nessuno. Questo mi piaceva – svegliava un ricordo di piaceri. E sfogava tutto in una volta un bisogno di lasciarsi andare, di appartenere. Perché da qualche tempo, così mi sentivo. Trattenuta, senza armonie. E mi sembrava di fare torto a Napoli, con il mio scontento, di misconoscere la sua bellezza, che pure mi incantava. Mai in nessuna città, prima, avevo visto un tale abbaglio di luce. Anche nei più angusti vicoli veniva – questa luce – a fendere le facciate scrostate. All’improvviso, da un momento all’altro, le ombre si aprivano. Ma Napoli era pur sempre città, e, come tutte le città, mi indeboliva. Giravo per le strade e non capivo come alla gente andasse bene, vivere in quel modo. Senza potersi sdraiare, dove si vuole, aderire alla strada come ci si lascia cadere in mare, su una spiaggia, o sopra l’erba di un prato. Ecco: io non aderivo più alle cose, in città. Non c’era comunione, tra noi. Quella prima visita al parco mi piacque, appunto, per l’impressione di ritrovata intimità. Stare là, nel prato, a guardare i gabbiani, mi restituiva al mondo delle sensazioni, oppure – che è lo stesso – mi restituiva a me stessa. Quando, superato il cancello, mi trovai di nuovo in strada, non erano ancora le dieci. Raggiunsi a passi lenti il grande albero, circondato di pietre. Dall’alto dei gradini osservai la città, giù in fondo, oltre il Tondo di Capodimonte. Poi cominciai a scendere, e mi abbandonai ai vicoli e alla luce un’altra volta.
